Di Riccardo Pasqualin
Il contesto storico: la terza guerra d’indipendenza
Il 15 settembre 1864 il presidente del consiglio Marco Minghetti (1818-1886), come coronamento di una strategia diplomatica mirata a rassicurare la Francia rispetto alle ambizioni del Regno d’Italia, stipulò con Napoleone III la “Convenzione di Settembre”, un accordo secondo il quale il governo di Parigi avrebbe dovuto impegnarsi a ritirare i suoi soldati da ciò che restava dello Stato della Chiesa (art. II), mentre l’esercito sabaudo avrebbe dovuto restare entro i confini italiani, non invadendo i territori pontifici ed anzi tutelandoli da eventuali aggressioni esterne (art. I).
A garanzia del patto, fu sottoscritto un protocollo che fissò il trasferimento della capitale italiana da Torino a Firenze. Il cambiamento fu attuato il 3 febbraio 1865, tuttavia già nelle giornate del 21 e 22 settembre 1864, diffusasi a Torino la notizia della firma della Convenzione di Settembre e delle conseguenze dell’“allegato segreto”, una folla aveva invaso Piazza Castello e Piazza San Carlo. Ne erano seguite gravi agitazioni e i contingenti militari che avrebbero dovuto mantenere l’ordine avevano attaccato i contestatori con sciabolate e scariche di fucile portando alla morte di 62 persone e al ferimento di altre 138; si registrarono poi ulteriori manifestazioni d’insofferenza di minor portata. Inoltre crebbe anche l’insoddisfazione dell’opinione pubblica nelle altre province, convinta che lo spostamento della capitale potesse anche significare una rinuncia a Roma.
Restava aperta la questione veneta, ma la situazione propizia per annettersi la regione si manifestò quando la Prussia inasprì il suo atteggiamento aggressivo verso l’Austria per estrometterla dalla Confederazione Germanica e compiere l’unificazione tedesca. Bismarck progettò di sfiancare l’Impero Asburgico impegnandolo su due fronti e stipulò un’alleanza militare col Regno d’Italia (8 aprile 1866), prevedendo, in caso di vittoria, la cessione della Venezia allo stato sabaudo.
Il conflitto Austro-Prussiano iniziò il 14 giugno 1866 e l’esercito italiano intervenne il 20 dello stesso mese. Come è noto, le forze sabaude non si mostrarono del tutto preparate e subirono due sconfitte umilianti: una per terra, Custoza (24 giugno 1866), e una per mare, Lissa (20 luglio 1866). Ottennero invece dei successi sul campo i corpi di volontari guidati da Garibaldi, che riuscirono a penetrare in Trentino battendo gli austriaci a Bezzecca (21 luglio 1866).
La possibilità che il Veneto venisse unito al Regno d’Italia generò grandissimi entusiasmi, che ispirarono non solo scritti politici, ma anche di carattere artistico: in questa occasione ci occuperemo di un lavoro teatrale risalente a quell’epoca, Nessuno va al campo del drammaturgo emiliano Paolo Ferrari (1822-1889), che ha per sottotitolo Episodj domestici del 1866. Si tratta di una commedia oggi ignota ai più – come vedremo, non senza una ragione – e prima di affrontarne le scene è necessario ripercorrere la biografia dell’autore.
Paolo Ferrari e la cultura veneta
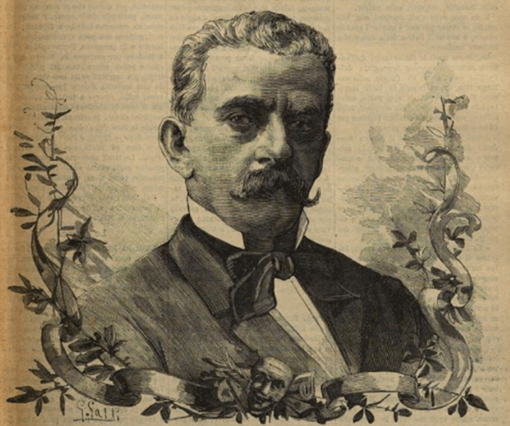
Paolo Ferrari in un ritratto apparso in Emporio Pittoresco (anno XXVI, n. 1281).
Paolo Ferrari nacque a Modena il 5 aprile 1822 e, secondo le modalità del tempo, compì i suoi primi studi in parrocchia e poi presso i barnabiti. Si distinse prestissimo per un certo estro creativo e satirico, ma iscrittosi al collegio legale dell’università della sua città – a causa della sua condotta turbolenta – non fu ammesso all’esame di laurea. La famiglia (il padre era ufficiale dell’esercito estense) riuscì tuttavia a far muovere in suo favore il Duca Francesco IV (1779-1846) in persona, che gli fece ottenere la laurea ad honorem in giurisprudenza il 19 luglio 1843[1]. Durante il 1848, lo scrittore entrò nella guardia civica cittadina, ma il fallimento della rivoluzione lo costrinse ad un breve esilio quasi “foscoliano” sui monti vicino a Vignola. Tornò a Modena dopo pochi mesi, ma non modificò i suoi sentimenti verso il governo legittimo.
Più che al diritto, si dedicò con impegno alla stesura di commedie e visse per anni tenendo lezioni di materie umanistiche per 4 o 5 ore al giorno. In questo periodo si appassionò allo studio dell’opera di Goldoni, cominciando dalle sue memorie per indagarne il genio. Il modenese si convinse che l’avvocato veneziano fosse un riferimento fondamentale da cui il teatro italiano avrebbe dovuto ripartire per tornare ad essere competitivo a livello internazionale. Si diede così alla stesura di una commedia dedicata ad alcuni episodi della vita del maestro: Goldoni e le sue sedici commedie nuove, che terminò nel 1851. Possiamo considerare quest’opera come l’unico vero lavoro degno di nota del Ferrari, che durante la sua carriera dovette fare spesso i conti con stroncature e insuccessi. Il testo unisce elementi di realtà della biografia di Goldoni, come il successo de La vedova scaltra nel 1748 e soprattutto la scommessa fatta nel 1750 con il suo pubblico e con Girolamo Medebach (1706-1790) di scrivere sedici commedie in un anno, ad altri di fantasia, come l’immaginario poeta e letterato Carlo Zigo (palese anagramma di Gozzi), presentato come «Personaggio ideale che raffigura i nemici di Goldoni, fra i quali era pure alcuno di non comune ingegno, come per esempio Carlo Gozzi»[2]. Tramite Zigo, secondo la sua sensibilità di uomo del risorgimento, l’autore espone anche l’ipotesi di una chiave d’interpretazione politica per La vedova scaltra, in cui la donna sola è la Repubblica Veneta su cui le principali potenze europee vorrebbero estendere la loro influenza[3]. In una battuta il Goldoni personaggio, in quanto avvocato, afferma poi: «non ho mandato alla forca nessun Fornaro innocente»[4], chiaro riferimento al dramma Il fornaretto di Francesco Dall’Ongaro (1808-1873) – poligrafo assai più talentuoso del Ferrari – che fu pubblicato a Trieste nel 1846 e, benché fondato su una semplice leggenda priva di solide attestazioni storiche, venne largamente apprezzato per le sue critiche alla tortura e alla pena di morte.
Ferrari scrisse diversi testi nella parlata di Modena, ma in questo inserisce due personaggi che si esprimono in veneziano: il patrizio Grimani e il suo servo Bortolo, dando prova – dopo aver tanto letto Goldoni – di avere padronanza di quel vernacolo. Il copione fu premiato in un concorso organizzato dal Ginnasio drammatico di Firenze, e messo in scena dalla Società filodrammatica di Modena l’8 aprile 1853.
Sempre in quell’anno, Ferrari tornò a confrontarsi con la cultura veneta scrivendo il dramma Dante a Verona, che fu giudicato negativamente e non degno di essere rappresentato[5]. Nelle intenzioni con cui questa commedia in cinque atti nacque, essa avrebbe dovuto apparire come il frutto di un grande studio storico sul massimo scrittore italiano, ma in realtà il risultato finale deluse il pubblico, che si trovò davanti una narrazione prolissa in cui la sottintesa reinterpretazione risorgimentale del Divin Poeta si sposa con una trama poco appassionante.
Intanto l’autore iniziò a manifestare problemi alla vista che nel 1854 lo costrinsero a dettare, più che a scrivere di suo pugno, La scuola degli innamorati, una commedia in stile goldoniano ambientata a Venezia con «costumi moderni», che nella città di San Marco fu fischiata dagli spettatori perché creduta una satira contro i veneziani[6]. Pur cercando di imitare Goldoni, Ferrari non comprese, o non riuscì a fare sua, la caratteristica che rese grande il suo mentore; Clotilde Castrucci, studiosa del commediografo modenese, scrisse che: «l’imperfezione degli autori italiani nel dipingere la società, dovè avere una causa tutta particolare, la poca cura dello studio dal vero, necessario al drammatico come al pittore, se della vita vuol cogliere quello che vi è di umano e quindi d’eterno. Anche il Ferrari non ebbe l’artistica intuizione della società contemporanea»[7], poiché egli non solo non trovò la sua personalità artistica, ma non riuscì neppure a entrare profondamente in contatto con gli ambienti che desiderava riprodurre nella finzione.
Nel 1859 il nostro partecipò alla rivoluzione di Modena, con l’annessione al Regno di Sardegna (15 marzo 1860) divenne segretario dell’università cittadina e poi, nel 1861, venne chiamato a Milano per insegnare Storia presso l’Accademia scientifico-letteraria; da allora visse nel capoluogo lombardo sino alla sua morte, sopraggiunta il 9 marzo 1889.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
[1] Vittorio Ferrari, Paolo Ferrari, Castoldi & C., Milano 1899, pp. 21-24.
[2] Cit. ediz. Borroni e Scotti, Milano 1854.
[3] Ivi, pp. 54-55.
[4] Ivi, p. 107.
[5] P. Ferrari, Prefazione, in Dante a Verona, Sanvito, Milano 1862, p. VII.
[6] Cfr. ediz. Bettoni, Milano 1868, p. 10 e nota.
[7] C. Castrucci, Il teatro di Paolo Ferrari, Lapi, Città di Castello 1898, pp. 11-12.
Nessuno va al campo
Veniamo quindi a quello che tra i copioni “veneti” di Ferrari più c’interessa dal punto di vista politico: Nessuno va al campo, opera scritta di getto nell’estate del 1866. Essa venne definita da Leone Fortis (1827-1896) una «commedia leggera»[8], ma si tratta innanzitutto di un esempio di letteratura patriottica, ovvero di un genere che stava già iniziando a venire a noia ai lettori. Si consideri che nel 1867 il capolavoro postumo di Nievo, Le confessioni d’un italiano, fu pubblicato col titolo Le Confessioni di un ottuagenario, imposto dall’editore Le Monnier per il timore che il libro potesse essere giudicato come un mero romanzo politico simile ai tanti altri già stampati in grande quantità.
Non v’è di che stupirsi, quindi, se nel 1871 il Nuovo giornale illustrato universale riportò che la commedia Nessuno va al campo, portata in scena, «non fece né caldo né freddo»[9]. Ferrari ritenne che i tiepidi entusiasmi fossero derivati dal troppo recente trauma di Custoza[10].

Ossario di Custoza, Sommacampagna (Verona)
L’opera apparve inizialmente in due puntate, e accompagnata da lunghi commenti, su Il Politecnico[11] come Bozzetto del giugno 1866; la prima edizione in volume è quella milanese di Barbini del 1871 (rivista in vari aspetti, ma in definitiva più impoverita che perfezionata dai tagli), da cui d’ora in avanti saranno tratte le citazioni (nelle edizioni successive i cambiamenti sono minimi).
La storia è ambientata a Milano e narra superficialmente alcuni frangenti della vita di una famiglia all’alba della terza guerra d’indipendenza. Inizialmente pare che nessuno dei personaggi maschi voglia arruolarsi per combattere e ciò desta le critiche dei servitori: i due camerieri Marco e Lucrezia, veneziano il primo e romana «de Tristevere» la seconda, che simboleggiano le due regioni d’Italia che ancora non erano state annesse al regno sabaudo, ossia la Venezia e il Lazio.
Mentre Lucrezia si esprime in romanesco, Marco parla veneziano e ciò contribuisce a rafforzare l’elemento veneto del testo teatrale, che altrimenti sarebbe praticamente sparito sullo sfondo dei fatti storici narrati. Non mancano neppure qui i riferimenti a Goldoni, e si parte subito con due battute sul caffè:
Marco:
[…] no ghe xe che a Venezia che se sapia far quelo che se ghe dise un vero caffè.
Lucrezia:
Abbiate pacenza, caro Marco, ma li forestieri dicheno che a Roma se fa er caffè meijo che a Venezia; e questo accade perchè nun c’ène in tutto er monno un’acqua più bona de quella delle nostre fontane. Figurateve che a tempo de Papa Sisto, l’imperatore quann’entronne in plazza de san Pietro e ch’assaggionne l’acqua delle dù famose fontane, se vortò a sua santità e je disse: Padre santo, fate fermane, fate! troppa spesa tutto sto rosoijo! e er Papa je rispose: Fijo, er rosoijo delli imperatori è l’acqua delle fontane der papa.» Vorreste dunque paragonà l’acqua de Roma con quella delli vostri puzzolenti canali de Venezia?
Marco:
Ohe, digo, non femo minga el cafè in canal, saveu!
Ma ben presto Marco espone il suo programma di guerra: «Cò sarà liberà el buzintoro de san Marco vegniremo a Roma a operar uno sbarco». Le ragioni per cui nessuno di casa voglia partire sono però immediatamente palesate: il banchiere Carlo, non ancora trentenne, non è trattenuto dalla moglie (Giulia, di sensibilità romantica e sostenitrice della guerra), bensì dalla sua attività lavorativa.
Sembra che il Marchese Giorgio Pompejani – nipote del Conte Giuseppe Restelli[12], e fresco di matrimonio con la cugina Sofia Restelli (donna tranquilla, spaventata dalla guerra), anch’ella nipote del Conte[13] – non possa partire per il fronte poiché ha un altro zio Cardinale borbonico, rifugiatosi a Roma a causa delle conquiste piemontesi, che potrebbe diseredarlo: «se er nipote fa er taijano [nel senso di sostenitore dell’unità d’Italia, italianissimo, nazionalista italiano]» spiega Lucrezia, il prelato potrebbe lasciare «[…] tutto all’ordine delli cavalieri de Malta». «Meteghe po de zonta che [Giorgio] el xe un marchese da Napoli» aggiunge il servo veneziano, «e par che ghe spuzza el fià de Borbonismo».
Il Conte Giuseppe, non ancora cinquantenne, è invece un massone repubblicano, reduce dei principali conflitti risorgimentali dalla “primavera dei popoli” in poi (capitano a Venezia nel ’48, maggiore a Roma nel ’49, volontario coi mille nel ‘60), ma non propenso a scendere a patti col governo regio. Risulta immediatamente intuibile come tramite quest’ultimo personaggio Ferrari faccia entrare direttamente la sua voce nella narrazione, e vedremo come ciò sia confermato anche dalla storia del testo. Il nipote di Giuseppe, Pio, cresciuto dal Conte come un figlio, non è arruolabile poiché abate sedicenne e sospetto di intransigentismo (pare che abbia «el non possumus in te la cerega»).
Il cameriere Marco è veneto, freme perché la Venezia sia unita al regno dei Savoia e ha pure una notevole carriera militare alle spalle, ma gli resta il cruccio che lo stato italiano non gli abbia ancora riconosciuto i suoi gradi:
«la mia parte la gho fatta! Soldà comun in tel 48 sotto Peschiera; pò son corso a Venezia in dove che i m’ha volesto far capitanio; pò via a gambe infinamente a Roma in dove i m’ha fatto subito sottocaporal; fin che del 59 son tornà soldà. Ma a San Fermo m’ho vadagnà i galoni de sargente; pò del 60 in Sicilia queli de forier! E se adesso el Ministero me torna a dar le mie competenze, come spero, si mo anca per diana che me vedarè là sul campo! … per la mia cara Venezia!»
In verità, davanti a paroni poco propensi alla guerra patriottica, Marco pare avere dei seri dubbi sul fatto di arruolarsi:
«co sti paroni che, chi per un radego, chi per un altro, de guerra no i ghe ne vol saver… Gho prová tempo indrio a dirghene una parola, ma gho capio che i gavarave fatto de man e de pie per mandar in fumo le mie pratiche col Ministero invece de ajutarme: onde gho dito tra de mi: Mi no divento mato altro».
Insomma, a meno che non si arruoli Lucrezia come vivandiera, potrebbe anche andare a finire che al campo di battaglia non ci vada nessuno.
Solo due personaggi, il Visconte Alcioni e il dottore Alberti, paiono sin dall’inizio decisi a partire.
L’adolescente Pio aspetta una lettera misteriosa a cui sembra tenere particolarmente, tuttavia la missiva che giunge è indirizzata al «vecio eretico» zio Giuseppe.
Nella terza scena del primo atto, il Marchese Pompejani sembra voler far credere che gli sia stato intimato dalle autorità di andare al confino in Svizzera a causa dei sentimenti borbonici della sua casata e della questione dello zio Cardinale: l’esilio sarebbe l’unica alternativa al domicilio coatto. Si tenga presente, infatti, che nell’esercito austriaco durante la guerra nel Veneto del 1866 erano presenti (soprattutto tra gli ufficiali) anche dei reduci dell’armata delle Due Sicilie, e che i sostenitori di Francesco II confidavano nella disfatta degli italiani.
Nella quarta scena del primo atto c’è una ripresa dell’argomento del caffè, con una battuta che associa l’abitudine di berlo amaro alle usanze veneziane. Si tratta solo di un pretesto per ritornare sulla questione veneta:
Giulia:
[…] Ah! quella Venezia che città leggendaria!… «Salutami Venezia, o gondoletta bruna!…»
Carlo:
(scherzando) Con la relativa Luna che si specchia nella fatal Laguna!
Giulia:
Se possiamo riuscire a liberarla quest’anno!
Carlo:
Ci riusciremo, moglie mia, ci riusciremo.
Giulia:
Non parlate in plurale, marito caro, non parlate in plurale. Ci riesciranno questi giovani qua! (accenna Alberti che le sta vicino e il Visconte che le porge il caffè) Oh se potessi fare di me un uomo!
Data la grande frequenza con cui l’espressione “gondoletta bruna” e la rima luna-laguna compaiono in molti componimenti, riconoscere il testo a cui alludono Giulia e Carlo non sembra un’impresa fattibile. Tuttavia in La scuola degli innamorati, rappresentata per la prima volta al teatro comunale di Modena nell’autunno del 1854[14], Ferrari aveva già inserito una frase simile:
Alle dieci un piccolo banchetto da Danieli contemplando la laguna, la gondoletta bruna!… Alle dodici… la luna – di miele![15]
Evidenza che ci fa propendere per un’autocitazione.
Nel secondo atto si scopre che Carlo è una camicia rossa ed è deciso a recarsi a Como per arruolarsi senza essere scoperto da sua moglie Giulia.
Infine si scioglie velocemente il debole intreccio della trama e tutti partono per la guerra. Marco riceve il pieno riconoscimento dei suoi gradi militari: «I m’ha tornà a dar el mio grado. […] San Marco benedetto me ciama e mi vago». Si scopre che il Marchese Giorgio non era stato costretto all’esilio in Svizzera, ma era invece pronto a partire spontaneamente anch’egli come volontario garibaldino, come aveva già fatto nelle campagne del ’59 e del ’60 fingendo di visitare l’Oriente.
Il Conte Giuseppe accorre direttamente alla chiamata del generale Garibaldi, ma riceve – apparentemente per motivi incomprensibili – una lettera contenente la fede di nascita di un primo figlio di sua sorella che era stato battezzato anch’egli Pio, ed era morto un anno prima della nascita dell’abatino: il mistero è presto svelato, Pio ha sfruttato la fede di nascita dell’omonimo fratello morto per spacciarsi per diciottenne e arruolarsi nella cavalleria, e a Piacenza incontrerà anche il suo maestro di Greco, che si è fatto soldato pure lui. Riguardo quest’ultimo dettaglio ricordiamo che Ferrari è vissuto per anni impartendo lezioni private.
Giuseppe riassume il mutamento generale:
«Questo veneziano [Marco] era un proletario e diventa un sott’ufficiale, quello là [Alcioni] era un visconte damerino, quell’altro [Alberti] era un dottore poeta e diventano due semplici soldati; l’erede dei legittimisti [il Marchese Giorgio Pompejani] si finge esiliato per andar volontario; il banchiere [Carlo] si finge fallito per correre al campo; il prete fanciullo [Pio] fa le carte false per diventare un eroe insieme al maestro di greco; e mentre le nostre donne generose [Giulia e la Marchesa Sofia] soffocano le loro lagrime e donano i loro cari al paese io solo dovrei rimanere a casa a brontolare? No, viva Dio! […] Sono con voi! Al campo!»
Raffaello Barbiera (1851-1934) ricorda Nessuno va al campo come una fotografia fedele del suo tempo: sembrava che nessuno volesse partire e invece tutti diedero il loro contributo[16]. Un fondo di verità in effetti c’è…
Il giornale L’O di Giotto, nelle Cronache teatrali del numero 42 (anno III) del 9 ottobre 1892, trattando della commedia Nessuno va al campo portata in scena nell’autunno del 1866 al Teatro Re di Milano[17], dalla compagnia di Alemanno Morelli (1812-1893), figlio d’arte di due grandi attori veneziani[18], racconta che:
«L’episodio del giovinetto Pio, che simula un attestato di sua nascita, sostituendovi quello di un fratello nato prima di lui e morto lattante, il Ferrari lo tolse di casa sua. Quell’impresa la fece il figliuolo di Ferrari, Augusto[19], poi avvocato».
E narra:
«Tranne la qualità di abate e della parentela, il giovinetto Pio e suo zio Giuseppe riproducono testualmente, fin quasi parola per parola, quanto passò tra Ferrari e il figliuolo».
Nell’articolo vengono quindi riportati i Cenni storici inseriti dal Ferrari nell’edizione del 1878, nella raccolta delle sue opere drammatiche:
«Mi par jeri quel giorno che il servitore mi portava, al mattino, la posta, e io, tra le altre, trovava una lettera del prevosto di Vignola, il quale mi mandava una seconda edizione della fede di nascita di quel mio figliuolo [che era] stato battezzato a Vignola (mentre ero profugo sopra i vicini monti nel settembre del 1848) e mi diceva d’aver mandato due giorni prima altra fede identica, giusta la premurosa domanda da me fattagli! – E io a tutta prima cascavo dalle nuvole! – poi indovinava tutto, agguantavo il cappello e correva via a riacchiappare il mio signor figlio, già passato alla visita, e già iscritto volontario! Per quell’anno lo fermai, avendo egli soli 16 anni, ma l’anno di poi me la fece! – Mi scappò, lasciandomi una letterina in cui diceva che “L’Italia non era compiuta e che andava…” – Va a compierla lui! – brontolai tra me. […] Fatto sta che egli fu così a Monte Rotondo e a Mentana»[20].
La commedia di Ferrari è indubbiamente un documento interessante sul volontarismo nella terza guerra d’indipendenza, tuttavia presenta evidenti limiti sia sul piano narrativo che su quello della costruzione dei suoi protagonisti. Sebbene la trama sia breve e gracile, il numero di personaggi appare eccessivo e, anziché arricchire l’impalcatura del fragile edificio, ciò rischia di generare confusione nello spettatore. Nella divisione tra servi dialettofoni e padroni italofoni, i due camerieri sono solo delle macchiette funzionali a rappresentare Venezia e Roma che attendono il tricolore. I personaggi in generale, inoltre, non sperimentano alcuna evoluzione psicologica e sono privi di profondità. Il vero volto di alcuni di essi si rivela al pubblico attraverso il colpo di scena finale, ma questo si compie in maniera frettolosa e priva di un’adeguata preparazione drammatica: è una mossa da teatro amatoriale di scarso livello. Inevitabilmente, ciò indebolisce l’impatto emotivo e narrativo dell’opera agli occhi di uno spettatore dei nostri giorni, che vivendo in un’altra epoca non è toccato dagli entusiasmi risorgimentali e messo davanti a una simile recita difficilmente può arrivare a comprenderli.
Come è stato scritto, la storia trae ispirazione da un episodio della vita dell’autore, ma anche qui Ferrari non è riuscito a sfruttare l’esperienza personale per creare una vicenda veramente realistica o almeno poetica. Ai difetti consueti dei lavori del drammaturgo, qui si somma per giunta una retorica poco originale, che sciorinata in meno di sessanta pagine accresce la debolezza strutturale del testo privandolo di incisività e impedendo a un pubblico non più toccato dalla temperie politica del 1866 di sentirsi in qualche modo coinvolto.
Nessuno va al campo va quindi a collocarsi nella categoria della letteratura politica di bassa lega anziché nell’ambito dell’arte vera teatrale: è e resta una chiamata alle armi, accompagnata dalla convinzione che la vita militare cancellasse le differenze di ceto. Nella stesura dell’opera la componente ideologica e l’intento propagandistico hanno prevalso sulla capacità, e forse anche sulla volontà, di plasmare una struttura apprezzabile. Le puntate del bozzetto originale del 1866 lasciavano intravedere almeno un quadro quasi compiuto, ma ciò si è perso con l’edizione in volume, non accresciuta bensì privata di diversi particolari e battute; comunque, in ambo le stesure non v’è neppure l’ombra di personaggi tridimensionali.
[8] L. Fortis, Paolo Ferrari. Ricordi e note, Treves, Milano 1889, p. 27.
[9] Cit. da articolo Il Corriere di Firenze, in op. cit., anno IV, n. 2, 8 gennaio 1871.
[10] P. Ferrari, Opere drammatiche, vol. sesto, Libreria Editrice, Milano 1878, p. 158
[11] Le due puntate apparvero sui numeri di agosto e settembre del 1866.
[12] «Giorgio: Aspettate. (a Carlo) Scrivo allo zio Giuseppe» (ediz. 1871, p. 45; cfr. anche ivi, pp. 46 e 49).
[13] «Giorgio: (commosso) Eccoci al punto! E Sofia?! – Non posso fare assegnamento sopra suo zio, il conte Giuseppe […]» (ivi, p. 16).
[14] Cfr. ediz. Bettoni, Milano 1868.
[15] Ivi, p. 98.
[16] Raffaello Barbiera, Il salotto della Contessa Maffei, Madella, Milano 1914, p. 175.
[17] Il Teatro Re fu progettato dall’architetto svizzero Luigi Canonica (1762-1844), venne inaugurato nel 1813 e demolito nel 1872.
[18] Morelli era figlio di Antonio (1769-1827) e Adelaide Salsilli (1795-1871), famosi attori drammatici veneziani che erano stati celebri per le loro interpretazioni goldoniane (Leonardo Spinelli, Elvira (detta Rina) Morelli (Napoli, 24 novembre 1908-Roma,17 luglio 1976), in «Drammaturgia», XVI, n.s. 6, 2019, pp. 194-195), fatto che lo rendeva certamente adatto, per formazione, alla rappresentazione del lavoro di Ferrari. Alemanno Morelli fu per altro il nonno dell’attrice Rina Morelli (1908-1976), che il 18 dicembre 1943 prese parte alla recita di Goldoni e le sue sedici commedie nuove di Paolo Ferrari presso il Teatro Argentina di Roma (ivi, p. 183).
[19] Augusto era il secondo figlio di Paolo Ferrari (E.R., Onoranze a Paolo Ferrari, in «I diritti d’autore», anno XI, n.5, maggio 1892, p. 40).
[20] P. Ferrari, Opere […], op. cit., pp. 158-159.

Paolo Ferrari, immagine pubblicata dal figlio Vittorio.

Firma dell’autore tratta dal sesto volume delle sue Opere drammatiche (1878).
Da “Storia Veneta n°80” – settembre 2025